 |
 |
INTRODUZIONE
di
Giana Amantina
Quando mi torna alla mente un episodio del passato, scriverlo per me è la cosa più facile del mondo.
Mi rivedo persino nelle gesta e negli atteggiamenti, a volte di stupore, come il giorno che sorpresi una mia compagna di scuola, nel bagno dei ragazzi, mentre si faceva toccare da uno di questi.
Quella
volta passai dallo stupore alla paura, perché non capii che i loro lamenti non
erano di dolore. Io però presi tanta paura che corsi ad avvisare la bidella,
con le conseguenze che potete immaginare.
Dopo
qualche tempo capii quanto ero stata stupida, ma il danno ormai era fatto.
Oppure
mi ricordo di quando decisi di scoprire il “miracolo della guarigione
veloce” delle mie sorelle, all’epoca ambedue fidanzate mentre io ero poco più
di una bambina.
Sta
di fatto che quando arrivava il fidanzato a casa, alla sorella di turno veniva
qualche malanno e, con quella scusa andava a chiudersi in camera.
Il
fidanzato dopo un po’ chiedeva il permesso alla mamma di andare a vedere se
stava meglio, passato un po’ di tempo, tornavano insieme tenendosi per mano
con l’espressione soddisfatta che aveva il mio gatto quando riusciva a fregare
qualche sventurato topolino, ma a parte il loro sguardo da pesce lesso ogni male
era sparito.
Quando
andavo in giro per i campi a fare esperimenti, mangiavo ogni tipo di bacca o
frutti che trovavo sul mio cammino.
Questi
esperimenti erano non di rado dolorosi: se le bacche erano acerbe, la mia pancia
diventava dura come un sasso, se erano troppo mature dovevo sperare di non
trovare l’unico gabinetto, che dividevamo con gli zii, occupato, altrimenti
dovevo correre dietro il muretto, dove le ortiche ben concimate crescevano
rigogliose.
Un
giorno che avevo di questi problemi, aspettai con ansia uno dei fidanzati.
Chi
non aveva importanza, tanto entrambi facevano i miracoli.
Gli
rimasi appiccicata per due ore sull’unico divanetto malconcio che era nel
tinello.
Alla
fine dovetti prendere ben due cucchiai d’olio di ricino, (questa era la cura
miracolosa di mia madre) così passavo dal niente al tanto. Onestamente non so
dire se stavo peggio col niente oppure con il tanto.
Ecco,
la mia vita è fatta di piccole storie, tutte raccontate e scritte così come
sono avvenute, dall’infanzia all’adolescenza, dai giochi alla scoperta del
sesso, o meglio alla scoperta del perché io per fare pipì dovevo chinarmi
mentre mio cugino poteva farla stando in piedi. .
Ma
anche questa è un’altra storia.
Se
il computer smettesse di mettere tante righine rosse per farmi notare che non
gli piace come scrivo, forse oggi avrei scritto tutta la mia vita.
Oppure
se volessi trovare parole “elaborate” non avrei che da consultare un
dizionario.
Per
essere onesta ho anche provato, ma quello che volevo dire, per me non aveva lo
stesso significato.
Per
scrivere quello che sento e quello che provo devo farlo in modo semplice.
Dove
sono nata e ho vissuto per gran parte della mia vita, non c’era tempo per
consultare un dizionario.
Ho
conquistato la terza media alle scuole serali, per raggiungere un mio scopo.
Ma
questa è ancora un’altra storia.
Non
posso cambiare il mio modo di descrivere gli avvenimenti.
Ora
che tanti anni sono passati, il mio spirito è rimasto giovane, il corpo ci
prova, ma anche io devo arrendermi all’evidenza.
Al mio specchio che guardo sempre meno volentieri dico: “Se solo tu riuscissi a riflettere l’immagine che è dentro di me!”.
Ho
trovato un compromesso, quando scrivo lo evito per un paio di giorni.
Essere
completamente felici per due giorni, credetemi, è il massimo, perché mentre
scrivo rivivo esattamente l’episodio che racconto.
Se
racconto un episodio dell’infanzia, mi basta chiudere gli occhi per ritrovare
ogni particolare nei minimi dettagli, dalle corse con il mio asino al quale, ero
convinta che con un po’ di allenamento sarei riuscita a farlo diventare più
veloce di un purosangue.
Oppure
mi ritrovo in cima alla grande quercia, dove una cornacchia aveva fatto il nido;
quel giorno mi convinsi che esistono gli angeli, e che quello che proteggeva me
ora sarà il capo di tutti gli angeli custodi, per la tenacia con la quale ha
salvaguardato la mia incolumità, e se a volte gli è andata male di certo non
è stato per negligenza, ma solo perché mentre facevo qualche danno e Lui si
organizzava io cambiavo idea, combinandone un’altro che
non si aspettava.
 Osservando
i bambini di oggi, che ogni genitore cerca di accontentare in tutte le loro
richieste, penso alla mia infanzia, alle povere cose che possedevo. Ancora oggi,
pensando ai sacrifici, che anch’io faccio, per dare ai miei figli quello che
non ho mai avuto, mi chiedo: “Sono più felici loro ora o io ai miei tempi?”
.
Osservando
i bambini di oggi, che ogni genitore cerca di accontentare in tutte le loro
richieste, penso alla mia infanzia, alle povere cose che possedevo. Ancora oggi,
pensando ai sacrifici, che anch’io faccio, per dare ai miei figli quello che
non ho mai avuto, mi chiedo: “Sono più felici loro ora o io ai miei tempi?”
.
Io non ho mai posseduto la bambola di plastica, che pure desideravo tanto; guardavo con invidia quella di una mia cugina, e che ogni tanto mi permetteva di toccare. Aveva grandi occhi azzurri, quando la tenevo in piedi, quegli occhi meravigliosi rimanevano spalancati, mentre quando la mettevo a letto gli si chiudevano; i suoi capelli erano ricci e morbidi come seta, si muovevano anche le gambe e le braccia.
Tutto questo non lo facevano le mie bambole, ricavate da alcuni ritagli di lenzuola ormai troppo vecchie per essere rammendate; disegnavo il viso con la penna: occhi, naso, bocca, facevo la sagoma di bambina e con le forbici ritagliavo il disegno, poi con ago e filo cucivo ogni parte di quella che sarebbe stata la mia amica e confidente. Per i capelli usavo i ciuffi delle pannocchie, di conseguenza le mie bambole avevano tutte i capelli rossi e crespi, ma non per questo erano amate di meno.
Ma il mio vero gioco era la fantasia, con quella scavalcavo le montagne, nessun ostacolo era per me insuperabile, niente riusciva a fermare il mio desiderio di scoperte sempre nuove.
Due barattoli di conserva vuoti, un pezzo di fil di ferro, un chiodo, erano per me un tesoro inestimabile per scoprire un nuovo gioco. Puntavo il chiodo nella parte chiusa del barattolo, due fori in corrispondenza ai lati, infilavo il fil di ferro attraverso i fori, e allacciavo i barattoli ben stretti sui piedi, come se fossero delle scarpe, ed ero pronta alla corsa. Dopo la prima prova, mettevo tra il fil di ferro e il dorso del piede, delle foglie fresche, così prima della carne erano le foglie a soffrire.
Allora non c’era la scelta dei grandi magazzini, niente era scontato.
Ogni gioco veniva ideato, creato e modificato, a seconda delle possibilità e degli oggetti che avevo a portata di mano in quel momento.
Io da bambina non ho mai visto gli scaffali colmi, dove la scelta del gioco è difficile, ed è quasi sempre una delusione.
Ogni novità era per me una sfida, una conquista o una sconfitta, ma comunque, sempre qualcosa di entusiasmante.
Il
lupo, l’orco, la strega ed ogni altro personaggio delle fiabe, che le mamme
spesso raccontano ai
loro figli, di solito per convincerli a mangiare e a stare buoni, spesso spaventano i bambini.
Mia madre non mi ha mai parlato di orchi, lupi o cose del genere.
Per me c’era la Zonca oppure la Mamma del sole; spesso mi raccontava di questi due personaggi, non per convincermi a mangiare, bensì nel tentativo di dissuadermi dall’andare in giro per giornate intere, nei campi vicino a casa.
Non nascondo che questi due personaggi chiunque fossero, mi incutevano paura, ma più forte della paura era il desiderio di scoprire come erano in realtà.
Mia madre, diceva che, la Zonca o la Mamma del sole, portava via i bambini che uscivano di casa nelle ore che il sole era alto in cielo. Per me era un motivo valido per fare tutto il contrario, dopo aver indagato sull’aspetto dei due “mostri” avevo ricevuto da mia madre, risposte piuttosto vaghe e per niente convincenti.
Mia madre diceva che la Mamma del sole era una vecchia che si travestiva da spaventapasseri, e appena vedeva un bambino andare in giro da solo, lo afferrava con le sue braccia ossute e dure, e non lo lasciava più.
La Zonca invece faceva finta di essere una roccia o un grosso sasso bianco, quando si avvicinavano i bambini disubbidienti, da sotto questi sassi, spuntavano lunghe braccia e mani munite di artigli, quindi per lo sfortunato bambino era la fine.
Quando decisi di scoprire quanto in realtà fossero cattivi, avevo circa sette anni.
Ricordo che mia madre quel giorno, subito dopo pranzo disse: “Andiamo a dormire un po’, così se passa la Mamma del sole o la Zonca vedono che dormiamo e non ci portano via”: Andai a letto con mia madre, ma quando lei si addormentò, mi alzai piano piano e uscii da casa.
Dopo qualche metro fui tentata di tornare indietro, guardavo continuamente intorno a me; c’erano parecchi spaventapasseri nei campi, uno era proprio di fronte alla mia casa, che faceva la guardia al campo di grano, aveva un vecchio cappello di paglia, dalle maniche, ormai a brandelli del vecchio cappotto di mio padre, una volta nero ora diventato grigio, spuntavano le braccia, sottili e perfettamente dritte; erano una vecchia scopa di saggina, infatti da una parte, al posto della mano c’era un pennacchio consumato, l’altra mano non c’era proprio; pensai: forse ha cercato di catturare un bambino, ma questo con un morso le ha staccato la mano.
Da bambina coraggiosa gli girai attorno, munita di una lunga canna, ogni tanto infilzavo il povero spaventapasseri che sussultava ma non si muoveva di un centimetro, anzi con la sua bocca storta, sembrava ridere delle mie paure.
Dopo averlo sfidato per alcuni minuti, mi convinsi che il poveraccio di quel campo non era la Mamma del Sole.
Decisi quindi di spostarmi al campo di granturco poco lontano.
Per
arrivarci dovevo attraversare un campo dove crescevano rovi e palme, ma
c’erano anche tante rocce bianche: “Vuoi vedere che mi frega la Zonca, forse
si è messa d’accordo con la Mamma del sole per farmi allontanare da casa, così
anche se dovessi gridare, mamma non mi sente, e non può correre a salvarmi.”
Così
mentre facevo un passo in avanti e tre indietro, alla fine mi diressi decisa
verso le rocce, tenendo la lunga canna diritta davanti a me; pensai al racconto
dei crociati che mia sorella mi aveva letto da un vecchio libro, e proprio come
un intrepido lanciere andai verso la conquista o la morte.
Ad
una distanza che reputai abbastanza sicura, infilai la finta lancia sotto il
grosso sasso, cercando di sollevarlo un po’, come il sasso si mosse lasciai
cadere la lancia, tenendomi pronta ad una fuga precipitosa; la pietra rotolò
via, sotto non c’era la Zonca ma una grossa lepre che al momento non riconobbi
e che aveva fatto la tana proprio vicino al sasso; mi passò fra le gambe ad una
velocità vertiginosa, credo che se il cuore non mi si è fermato in quel
momento per lo spavento, se oggi dovrò morire, non sarà certo per un infarto.
Rimasi
immobile per qualche minuto, il cervello mi ordinava di scappare, ma il resto
del corpo si rifiutava di obbedire. Ancora con le gambe che tremavano, mi
allontanai di qualche passo dal sasso e ricordando la lepre pensai: “Poverina,
l’ho proprio spaventata a morte”.
Raggiunsi
il campo di mais e girai attorno all’altro spaventapasseri. Questo indossava
una gonna colorata, e aveva in testa un fazzoletto che una volta doveva essere
bianco, ora era di un colore difficile da definire; gli uccelli si erano
talmente abituati alla sua presenza nel campo, che stavano tranquillamente
appollaiati sulla sua testa e sulle braccia.
“Forse
la Mamma del sole li ha addomesticati, per convincermi che è innocua, magari
appena le vado vicino mi prende e non mi lascia più” pensai; andai avanti di
qualche passo gli uccelli volarono via, ed io, con la canna che avevo
recuperato dopo lo spavento, iniziai a punzecchiare lo spaventapasseri.
Ma
anche questa volta non successe niente.
Passai
circa due ore a girovagare nei campi alla ricerca dei mostri mangia bambini.
Alla
fine mi convinsi che mia madre mi aveva raccontato una bugia; buttai via la
lunga canna ed andai in un campo 
dove crescevano i rovi e i cespugli di
corbezzoli e mi misi a raccogliere le more e i rossi frutti rugosi e dolcissimi
della pianta dei corbezzoli.
Mi resi conto che si era fatto tardi solo dopo essermi saziata con i caldi e dolcissimi frutti: “Se mamma si sveglia prima che io sia rientrata sono dolori”;
iniziai a correre verso casa, saltando ogni ostacolo che incontravo
sul mio cammino; fu proprio mentre saltavo una grossa pietra bianca che mi
sentii afferrare la maglietta, caddi lungo distesa: “Sono morta, mi ha preso
la Zonca”, senza voltarmi, per paura di vedere le sue mani adunche, cercai di
divincolarmi, sentii il dolore dei suoi graffi sulla spalla, ma con la forza
della disperazione riuscii a liberarmi e scappare, un pezzo della mia maglietta
era rimasto nelle sue mani.
Dopo
un po’ mi fermai, raccolsi dei sassi, tirai su il davanti della maglietta e vi
misi dentro i sassi, tornai indietro per affrontare la malefica vecchiaccia.
Con
un grosso sasso stretto nella mano destra, raggiunsi il punto dove la strega mi
aveva preso, ma non vidi niente di anormale, solo il lembo della mia maglietta
impigliato in un ramo di rovo,
“Ho
avuto paura della mia forza ed è scappata”, pensai.
Quando
restavo fuori di casa fino a tardi, per farmi perdonare da mia madre, andavo nei
campi appena arati dove si trovavano grosse radici di piante sradicate dal
passaggio dell’aratro.
Non
era facile trasportarle fino a casa, il terreno era troppo impervio, ed io ero
troppo esile; quindi avevo ideato un sistema per quel pesante, difficile lavoro,
ogni volta che mi allontanavo da casa portavo con me una corda, che mio padre
aveva ottenuto intrecciando le palme una all’altra, fino ad ottenere una fune
resistente, cercavo delle radici molto grosse, riuscivo a legarne insieme anche
quattro, facevo passare la corda sulla spalla e iniziavo a trainarle, ogni tanto
sentivo lo strappo della fune sulla pelle, allora mi fermavo, spostavo le radici
dall’ostacolo che le aveva trattenute, e riprendevo a tirare la mia croce e la
mia salvezza dalla punizione.
Più
grande era il mio ritardo, più grandi erano le radici che portavo a casa, di
solito mia mamma non aveva il coraggio di punirmi dopo tanta fatica, e il
pensiero che quelle radici ci avrebbero scaldato durante il rigido inverno,
avevano il potere di addolcire anche lei.
Quel
giorno non avevo portato la solita corda, quindi non potevo portare la legna,
quando tornai a casa trovai mia madre sulla porta ad aspettarmi, mi resi conto
che non dovevo avere paura della Zonca o della Mamma del Sole,
perché mia madre quando riusciva a prendermi non mi mollava più.

Le
mie sorelle erano nate sotto un cespuglio di rose; erano belle, grassocce, con
le guance rosee.
Io ero nata sotto un cavolo.
Da bambina non sono mai riuscita a spiegarmi questa differenza. Allora credevo che le mie sorelle, erano così belle per la differenza delle due piante, unica consolazione: la mia pianta si mangiava, magari non volentieri, però serviva a qualcosa. C’era anche un altro fatto che mi dava da pensare: durante le vacanze i parenti facevano a gara per ospitarle, mentre nessuno mi voleva.
Ero
convinta che loro due erano così docili e ubbidienti perché erano nate sotto
le rose.
Io, invece, ero nata sotto un cavolo, la pianta oltretutto emanava un cattivo odore.
Non ero grassottella e non avevo le guance rosa, anzi, ero secca come un bastoncino, odiavo i vestiti e tutto quello che mi impacciava soprattutto quando dovevo correre, arrampicarmi sugli alberi, o cercare di montare il nostro asino, per domarlo.
Quando la mia mamma mi costringeva a indossare il vestito e mi raccomandava di non strapparlo, mi sentivo come se mi avesse castigato ingiustamente. Allora, non appena riuscivo ad eludere la sua sorveglianza, ed ero a distanza di sicurezza, mi spogliavo, nascondevo il vestito dentro un cespuglio, ed andavo in giro con le sole mutande. Quindi, avevo sempre la pelle scura.
Ricordo le battute delle zie rivolte alla mamma, quando venivano a trovarci: "Sei sicura, che il padre sia lo stesso delle altre due? E’ piccola, nera, sembra soffra la fame. Non riesce a stare un minuto ferma”. Mia madre rispondeva sempre: “Ha preso tutto dal padre; se non fosse così piccola sarebbe uguale”.
L’unica cosa che ho afferrato subito è che certo non era un complimento, considerando l’opinione che aveva del babbo.
Solo il mio padrino e la mia madrina non potevano sottrarsi dall’ospitarmi, almeno per una settimana, quando terminava il periodo scolastico.
Penso che lo facevano più per cortesia verso mia madre che per il piacere di avermi con loro.
Per me, l’unico lato, positivo, era che, per una settimana, non incorrevo nelle ire di mia madre. Essi si limitavano a sgridarmi.
Io adoravo il mio padrino; aveva sempre un sorriso dolce per me e sembrava non arrabbiarsi per le mie “marachelle”.
In quel tempo succedevano per me cose straordinarie.

Ricordo che un giorno si era andati tutti al mare; per tutti intendo dire gli zii e qualche vicino. Il mio padrino era un agricoltore e io lo pensavo come un uomo ricco. Aveva una casa di quattro stanze e, nel cortile, c’era persino una stanzetta col gabinetto. Ricordo che al proposito cercavo di “farla” anche quando non mi scappava, tanto ero entusiasta della novità. Finalmente non dovevo chinarmi tanto e lì non c’erano ortiche, che pizzicavano tanto. Il padrino aveva anche il trattore, la mietitrebbia e un autocarro molto importante e questo era il mezzo di trasporto per la gita al mare.
Non ricordo i visi delle persone sedute dentro il cassone dell’autocarro, so soltanto che tutti intonavano canzoni e ridevano. Il mio padrino, prima di partire, mi aveva dato un’enorme anguria di “Benetutti”, erano le più grosse che avessi mai visto; mi aveva fatto sedere con le gambe aperte, mettendo al centro l’enorme frutto e raccomandandomi di tenerla ben ferma, in modo che non fosse pestata. Ero orgogliosa che, fra tanti adulti, avesse scelto proprio me per un incarico così importante e solo dopo alcuni anni mi venne il sospetto, che l’avesse fatto solo per tenermi ferma, senza il rischio di perdermi durante il viaggio. Dopo tanti chilometri percorsi su una strada non asfaltata piena di buche e di polvere, si arrivò al mare. Tutti scesero dal camion, massaggiandosi le parti ammaccate ma nessuno si curò di me, sempre seduta con l’enorme anguria fra le gambe e dopo che il padrino mi ebbe liberato dall’ingombro, faticai non poco a muovermi. Ero arrivata al mare, ma stando seduta di spalle, non l’avevo visto. Ora ero in piedi e il mare era lì, davanti a me. Ne avevo sentito parlare, ma non immaginavo, fosse così grande. Eravamo in un posto chiamato l’Argentiera, nome dovuto alle vecchie miniere d’argento, ormai in disuso. Non c’era sabbia ma tanti sassolini candidi misti a pezzetti di conchiglia, erosi dall’acqua e dal vento. Il mare non era calmo, e l’acqua arrivava alla spiaggia con tanta schiuma. Per questo motivo erano tutti delusi. Io no: non avevo mai visto il mare, quindi non riuscivo ad immaginare uno spettacolo più bello; mi sembrava di vedere il mio asino, quando non voleva farsi montare e scalciava, ostinatamente. Sentivo tutta la forza che veniva da quell’enorme distesa d’acqua; c’era in essa quasi una sfida nei miei confronti. Provai rispetto per quello che avevo davanti; sentivo, che avevamo tante cose in comune.
L’unica differenza era che io, spesso, dovevo lasciarmi dominare. Quel giorno sfidai il mare, dopo averlo contemplato e ammirato decisi: se ero riuscita a domare il mio asino e a cavalcarlo, a maggior ragione potevo riuscire a domare quelle onde, oltre tutto non le avevo mai viste tirare calci.
Quindi partii a passo deciso e mi ritrovai sommersa, ancora prima di capire in che modo le onde mi buttassero sulla riva e poi mi riprendessero. Scoprii che l’acqua era salata, per niente gradevole, e intanto una mano mi afferrò, tirandomi per la maglietta bagnata e di peso mi adagiò sulla spiaggia. Era il mio padrino che, chissà perché, non mi aveva perso d’occhio. Ora, a gambe divaricate e mani sui fianchi, mi guardava e rideva.
Fui relegata sotto l’ombrellone; gli adulti fecero quasi circolo intorno a me e non ebbi neanche il permesso di poter raccogliere le conchiglie sul bagnasciuga. Così, una giornata meravigliosa si trasformò in una tortura.
Guardavo le onde gigantesche, infrangersi contro gli scogli e per la prima volta, nella mia vita, provai invidia per quella forza e libertà che nessuno, mai, sarebbe riuscito a dominare.
Quella breve vacanza finì presto, ritornai a casa, non m’aspettavo certo un’accoglienza calorosa infatti, non l’ebbi: “è finita la pace” dissero all’unisono le mie sorelle, “non farmi arrabbiare” concluse mia madre.
Mi levai le scarpe della festa, indossai quelle vecchie e andai alla ricerca di mio padre, in quel momento era senz’altro con le pecore al pascolo. Quando fui sicura che dalla casa non avrebbero potuto vedermi, mi spogliai, nascosi il vestito dentro un cespuglio e rimasi così, con le sole mutande. Il mio corpo era esile, ma ben proporzionato, era un corpo di bambina ancora acerbo, senza niente di femminile, ma il tempo avrebbe donato a quell’esile, minuta figura qualcosa che le mie sorelle maggiori avrebbero invidiato non poco.
Iniziai a correre, le scarpe più grandi di qualche numero dei miei piedi mi impicciavano, così mi fermai, legai i due lacci insieme e le buttai a mò di zaino sulla spalla. Ora ero finalmente libera, correvo come una gazzella, incurante della spine, saltando ogni tanto un ostacolo.
“Babbo, babbo sono tornata” gridai vedendo alla fine della “tanca” la figura di mio padre.
“Dove hai messo i vestiti?” chiese abbracciandomi “dentro il cespuglio di rovo”
“Se ti vede tua madre sono guai, ti ricordi, vero, il punto giusto?”
Qualche volta avevo nascosto i vestiti, poi non mi ero ricordata dove,
“Sì ba’ me lo ricordo, adesso li metto sempre nel solito posto”
“Vieni qua, raccontami”
Raccontai della mia breve vacanza, soprattutto della stanzetta dove era il gabinetto e di tutte quelle volte che l’avevo usata.
Gli dissi della gita al mare, dell’enorme anguria che avevo curato per tutto il viaggio.
“Ba’, il mare è davvero grande, sembra la <tanca> di zio Antonio, anche se guardi lontano finisce in cielo, c’erano anche le onde, con tanta schiuma, io ci sono entrata, ma mi hanno buttato giù, poi padrino mi ha tirato fuori, e mi hanno fatto stare seduta tutto il giorno.
Ba’ lo sapevi che il mare è salato?”
Babbo mi guardava, capiva la sofferenza che dovevo aver provato costretta a star seduta.
“Vedrai, prima a poi al mare ti ci porta babbo e allora potrai fare tutto quello che vuoi”
“Davvero ba’ mi porti?”.
Mi alzai ed andai a richiamare alcune pecore che si erano allontanate.
Tornammo a casa insieme, mano nella mano.
Arrivati al cespuglio dove avevo nascosto il vestito lo presi e lo indossai, “brava”, mi disse mia madre, “non ti sei sporcata”.
Babbo e io ci scambiammo uno sguardo di complicità.
“Adesso porta tutti quegli avanzi al maiale, chissà che non si decida a ingrassare così a Natale mangeremo almeno le salsicce.”
Quel
maialino era la mia pena, lo avevo visto nascere, il pensiero che dovesse finire
in salsicce mi tormentava, l’unico modo per evitarlo era sottrargli il cibo
che mia madre gli dava in abbondanza.
Quindi presi il secchio con gli avanzi di verdure varie e andai a buttarlo nel fosso lontano da casa, poi mi fermai vicino al maialino e lo accarezzai: “lo faccio per te” gli dissi “se mangi mamma ti ammazza”.
La povera bestia avrebbe forse preferito la felicità del momento, piuttosto dell’agonia di tutta una vita, quindi cercava di infilare il muso dentro il secchio ormai vuoto.
Ogni volta che mia madre andava dal maiale, lo guardava, scuoteva la testa e diceva che io, il babbo e il maiale non saremmo mai ingrassati. Il giorno successivo si prospettò di tempo splendido, non c’era neanche una nuvola, una leggera brezza fece in modo di rinfrescare un po’ la giornata, che diversamente sarebbe stata torrida.
“C’è un sole che spacca le pietre” soleva dire mia madre, “oggi vado a <zinzaru>” pensai io, i dolci frutti delle palme piacevano anche alla mamma. Sapevo anche di dover contendere quel prezioso frutto con le vespe, che sceglievano come casa proprio la base delle palme, più frutti c’erano, più vespe trovavo.
Quel giorno, prima di uscire di casa andai a cercare un vecchio pentolino, che mia madre aveva buttato via, avevo ideato un sistema per neutralizzare le vespe.
Quando arriva alla Tanca dove c’erano le palme, tirai giù le mutande, mi chinai e feci la pipì dentro il vecchio pentolino, avevo pensato di buttare la pipì sul nido delle vespe sperando di vederle agonizzare; per prudenza prima mi tolsi le scarpe, se l’esperimento non avesse funzionato dovevo essere pronta a una fuga precipitosa. Infatti le vespe non morirono, tardarono solamente un po’ di più ad alzarsi in volo, giusto il tempo di raccogliere i dolci frutti.
SERAFINO PUROSANGUE
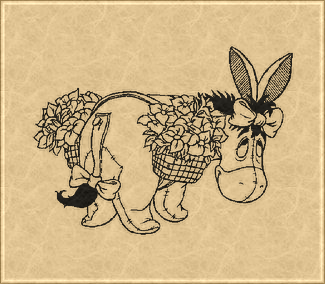 Una
delle mie passioni era montare sull’asino ed andare in giro per i campi, cosa
che neppure mio padre mi concedeva volentieri. Mi ripeteva sempre: ”Poverino,
lavora già così tanto…”. Spesso approfittavo così della sua assenza,
quando portava le pecore al pascolo sul fiume. Mi ero fissata di iscriverlo ad
una competizione di corsa. Mi avevano impressionato alcune immagini di stupendi
cavalli che gareggiavano, così mi
ero convinta che, con una bella strigliata tutti i giorni e con molta pazienza,
sarei riuscita a trasformare il mio asino in un perfetto purosangue. Fu così
che, in poco tempo, Serafino divenne l’asino più pulito e lucido di tutto il
circondario. L’addestramento procedeva invece con risultati meno brillanti. In
particolare non riuscivo a togliergli il vizio di puntare improvvisamente le
zampe anteriori ad ogni tentativo di farlo trottare, col risultato di brusche
frenate e mie conseguenti rovinose cadute. Non di rado atterravo su spine o
sassi ed il ritorno a casa era simile a quello di un reduce ferito in battaglia.
Il vero dramma era poi quello di non potermi lamentare per il dolore, neppure
quando mia madre mi infilava nella tinozza e, con una spazzola simile a quella
che io usavo per Serafino, tentava in modo energico di togliermi lu pingu
(sudiciume). Altra brutta abitudine del mio futuro corsiero era quella di
fermarsi ogni volta che scorgeva un cespuglio, di cui era assai ghiotto. In
questo caso non c’erano alternative: a nulla servivano carezze o calci, parole
dolci o minacce. Fintanto non si sentiva sazio, dovevo rassegnarmi ed aspettare
che si fosse sfamato.
Una
delle mie passioni era montare sull’asino ed andare in giro per i campi, cosa
che neppure mio padre mi concedeva volentieri. Mi ripeteva sempre: ”Poverino,
lavora già così tanto…”. Spesso approfittavo così della sua assenza,
quando portava le pecore al pascolo sul fiume. Mi ero fissata di iscriverlo ad
una competizione di corsa. Mi avevano impressionato alcune immagini di stupendi
cavalli che gareggiavano, così mi
ero convinta che, con una bella strigliata tutti i giorni e con molta pazienza,
sarei riuscita a trasformare il mio asino in un perfetto purosangue. Fu così
che, in poco tempo, Serafino divenne l’asino più pulito e lucido di tutto il
circondario. L’addestramento procedeva invece con risultati meno brillanti. In
particolare non riuscivo a togliergli il vizio di puntare improvvisamente le
zampe anteriori ad ogni tentativo di farlo trottare, col risultato di brusche
frenate e mie conseguenti rovinose cadute. Non di rado atterravo su spine o
sassi ed il ritorno a casa era simile a quello di un reduce ferito in battaglia.
Il vero dramma era poi quello di non potermi lamentare per il dolore, neppure
quando mia madre mi infilava nella tinozza e, con una spazzola simile a quella
che io usavo per Serafino, tentava in modo energico di togliermi lu pingu
(sudiciume). Altra brutta abitudine del mio futuro corsiero era quella di
fermarsi ogni volta che scorgeva un cespuglio, di cui era assai ghiotto. In
questo caso non c’erano alternative: a nulla servivano carezze o calci, parole
dolci o minacce. Fintanto non si sentiva sazio, dovevo rassegnarmi ed aspettare
che si fosse sfamato.
Avevo quindi un’impellente necessità di trovare un espediente per farmi ubbidire. Passai quindi qualche giorno in casa per trovare la soluzione al mio problema. Mi accorgevo che mia madre mi osservava preoccupata.
“Ma come, - pensavo – è possibile che non sia mai contenta? Si lamenta quando vado in giro, ora si lamenta perché resto in casa. Valle a capire, le mamme…”.
All’improvviso ecco l’idea, fulminante, splendida, geniale. Mi ero appena fatta un piccolo taglio ad un dito mentre pulivo i peperoncini.
Il bruciore era stato insopportabile e d’istinto mi misi il dito in bocca e poi cercai sollievo nella pentola dell’acqua fredda.
Ecco la soluzione magica: bruciore – corsa – acqua!
Attesi che mia madre facesse il suo solito sonnellino pomeridiano; il babbo era al pascolo, le mie sorelle ancora a scuola ed io libera, libera finalmente di convertire Serafino in un purosangue.
Sorse però un ulteriore problema: dove mettere l’acqua? Non in una bottiglia di vetro, mi ero tagliata da poco con un coccio di vetro e quindi non era il caso di correre ulteriori rischi. Non avevamo bottiglie di plastica ma… c’era la camera d’aria della bicicletta di babbo. Pensandoci bene, era anche più comoda, sarebbe bastato tagliarla a metà, riempirla d’acqua e legare le estremità con lo spago. Era veramente molto semplice, oltretutto potevo tenerla sul collo ed avere le mani libere. Se Serafino avesse galoppato come previsto, cavalcando senza sella avrei dovuto tenermi ben stretta alla sua criniera.
Mentre studiavo tutto questo, la voce di mia madre mi fece sobbalzare.
Era comparsa silenziosa nella stanza e, imperiosa, mani sui fianchi, tuonò: “Cosa pensi di combinare ancora?”.
Le rivolsi uno sguardo tranquillizzante e, con consumata malizia, sfoggiando il mio sorriso più accattivante, la rassicurai, invitandola a tornare a dormire. Dovetti attendere circa mezz’ora per essere certa che si fosse riaddormentata.
Mamma era di natura sospettosa, tanto che babbo sosteneva che dormiva come le lepri, cioè con un occhio solo, per non essere mai presa alla sprovvista. Questo babbo l’aveva sperimentato a sue spese, quando aveva tentato di prendere di nascosto la bottiglia del vino dall’armadio, nella certezza che lei dormisse. Peccato che se la ritrovò, sbraitante, seduta sul letto, prima ancora che avesse portato a termine il suo progetto.
Origliai dalla porta socchiusa per accertarmi che dormisse. Il suo respiro era regolare e rilassato, non c’era pericolo.
Corsi al recinto, saltai sulla groppa di Serafino che stava sonnecchiando e mi allontanai il più possibile da casa.
Avevo raccolto nel fazzoletto due peperoncini belli grossi, mi ero avvolta al collo la camera d’aria riempita d’acqua e fui pronta per il mio progetto. Avevo un solo dubbio: come usare il peperoncino? Avrei potuto farglielo mangiare, ma avrebbe scosso troppo la testa con conseguenze non prevedibili, quindi non avevo alternativa: dovetti girarmi sulla groppa di Serafino. Con la testa rivolta alla coda.
“Se parte a razzo – pensai – non ho il tempo per rimontare. Così, invece, prima che parta, riuscirò a rigirarmi per il verso giusto”.
Alzai la coda della povera bestia e sfregai con forza il peperoncino. Prima uno sbuffo, poi violenti e veloci movimenti della coda, destra e sinistra, alto e basso, destra e basso, sinistra e alto… Tentai di rigirarmi nella giusta posizione, ma l’asino scalciò improvvisamente e così violentemente che quasi assunse una posizione verticale. Poi partì più veloce di una saetta.
Riuscii miracolosamente ad aggrapparmi alla criniera, ma non ero riuscita a girarmi, quindi ero seduta fra il collo ed il dorso. In quella posizione non riuscivo ad assecondare il suo ritmo, quindi quando sgroppava, andavo in alto per scendere poi pesantemente.
Sono certa che Serafino stesse soffrendo, ma non sono certa di chi dei due stesse soffrendo maggiormente.
Nel frattempo, fra un sobbalzo e l’altro, avevo perduto la camera d’aria con l’acqua, unico mezzo indispensabile per poter alleviare il suo bruciore e quindi calmarlo. Unica consolazione, ma in quei momenti poco apprezzata, era l’aver notato che, da asino, si era certamente mutato in purosangue, e che purosangue…
Il terreno era roccioso, e questo accentuava i miei sobbalzi. Pregavo intensamente affinché si dirigesse verso un terreno più morbido, affinché potessi lasciarmi cadere prima che mi disarcionasse. Avevo previsto che il bruciore potesse durare dieci minuti (miei, ma quanti dell’asino?), ma sapevo che sarebbero stati i dieci minuti più lunghi della mia vita. Finalmente, non so dopo quanto, trovai un’area idonea ad un mio atterraggio morbido.
Non fu propriamente un atterraggio indolore, in quanto ero caduta sull’unico pezzo di roccia frastagliata di tutta la campagna. Avevo un gomito scorticato e contuso ed una natica massacrata. Serafino continuava a sgroppare ed a correre. Peccato non avere un orologio per poterlo cronometrare…
Pensai seriamente che non lo avrei più rivisto, quando finalmente si fermò.
Zoppicando lo raggiunsi, cercai di accarezzarlo. In risposta mi soffiò in faccia e digrignò i denti. Infuriata pure io, gli mostrai le mie ferite sul gomito e sulle natiche e, ultima minaccia, l’altro peperoncino rimastomi.
Non so se si commosse per le mie ferite o si terrorizzò all’odore del peperoncino, sta di fatto che raccolsi due foglie di fico selvatico, una per lui ed una per me. Tanto, le parti del corpo bisognose di cure erano le stesse.
Fin’ ora ho riportato fedelmente alcuni episodi della mia infanzia.
Oggi
vorrei parlare di mio padre, come lo vedevo quando ero una bambina; quello che
provavo per lui; le tante volte che avrei voluto essergli d’aiuto; la frustrazione per la mia incapacità di non essere
riuscita a dargli quella serenità che, ero convinta, gli fosse dovuta.
essergli d’aiuto; la frustrazione per la mia incapacità di non essere
riuscita a dargli quella serenità che, ero convinta, gli fosse dovuta.
Ho sempre pensato, che mio padre, fosse, oltre a me, la vittima di mia madre.
Per quanto cerchi di andare indietro nel tempo, ricordo di non averli mai visti scambiarsi un gesto di tenerezza, né di averli mai sentiti parlare in modo normale.
Sentivo
sempre mia madre urlare; mio padre difficilmente provava a ribattere: preferiva
uscire di casa e io, a volte, lo avevo seguito a distanza, senza farmi scorgere.
Egli andava sempre a sedersi ai piedi di una vecchia, grossa quercia. Non so
perché avesse scelto quel posto per la sua solitudine, forse perché era
l’unico albero vicino alla casa, o forse per cercare in esso quella forza che
a lui mancava.
Sono passati quaranta anni, eppure penso spesso a mio padre: non riesco a vederlo in un posto diverso. Per quanto frughi nella mia memoria, lo vedo sempre lì, ai piedi della vecchia quercia, seduto con la schiena appoggiata all’enorme tronco, con le lunghe gambe piegate, con i gomiti appoggiati sulle ginocchia e le mani a coppa per trattenete il capo, come a sorreggere l’enorme peso.
Solo una volta ebbi il coraggio di andargli vicino. Senza parlare, mi sedetti vicino a lui, imitandone la posizione.
Mi guardò con tanta tristezza; allungò il braccio e mi strinse a lui. Sono certa che piangesse; sentivo battere il suo cuore, ed il suo petto.
Era talmente scarno che sentivo le sue costole contro la mia guancia. Non mi mossi, né parlai; per me era un momento magico. Mai l’avevo sentito vicino come allora.
Non riuscivo a capire perché mia madre non fosse gentile con lui; per me era la persona più dolce e buona che conoscessi.
Non
capivo perché le poche volte che parenti ed amici venivano a trovarci avessero
verso mio padre un comportamento così strano.
Allora ero solo una bambina, ma percepivo la sua sofferenza e il suo disagio.
Anche oggi, mentre scrivo, sento la stessa rabbia di allora, ma da bambina, in quelle occasioni, provavo anche vergogna, non solo per gli ospiti, ma soprattutto per mio padre che non faceva nulla per zittirli e difendersi. In più credevo di odiare mia madre, che sembrava divertirsi del suo imbarazzo.
Se allora mi avessero rivolto la domanda: a chi vuoi più bene? Al babbo o alla mamma? Avrei risposto: al babbo. Per me era lui che aveva bisogno d’aiuto e che almeno una persona lo amasse. Ma ero talmente insignificante che nessuno dei parenti mi pose una simile domanda.
Non è molto quello che ricordo di mio padre, forse perché ho tenuto dentro solo i momenti a me più cari. Le rare volte che lo avevo visto sorridere, era quando aveva bevuto un po’, ed io ingenuamente, cercavo di rubare sempre un po’ di vino, che mia madre custodiva e controllava come un soldato il suo fucile, per darglielo di nascosto.
Anzi devo dire che quando mi sentivo accusata ingiustamente, ed ero triste, ho provato più volte a berne qualche sorso, per farmi venire la voglia di ridere. Aveva uno strano sapore, per niente gradevole; era quasi una medicina; faceva passare la tristezza, però aveva come effetto collaterale il mal di stomaco, e qualche volta mi faceva vomitare. Non dico che rinunciai subito ma limitai tale medicina ai momenti di estremo abbattimento; anche perché il mio babbo ne avevo più necessità di me, quindi dovevo conservarne il più possibile per lui.. Volevo donargli tanta felicità, ed ogni mezzo sembrava buono per fargliela raggiungere.
Un’altra mia premura era quella di procurargli il tabacco; un po’ sopperivo a quella necessità con le monete che riuscivo ad avere dai miei cognati, ma non erano mai abbastanza. Una sigaretta, allora, costava cinque lire e qualche volta la signora dello spaccio non me le vendeva.
Un giorno, al ritorno della scuola, scesi dal pullman due fermate prima. La mattina dal finestrino, avevo visto un cespuglio strano e volevo scoprire che cosa fosse. Quindi per tornare a casa, anziché passare per i campi, come facevo solitamente, percorsi la strada asfaltata. Lungo i margini, ogni tanto, trovavo qualche mozzicone di sigaretta che iniziai a raccogliere per gioco; poi iniziai a togliere il poco tabacco rimasto e a metterlo nella tasca del grembiule.
Quando ne avevo raccolto un bel po’, ero al settimo cielo, pensando alla felicità del babbo, quando glielo avrei donato.
Non fu esattamente così: ricordo che mi sgridò ed io ci rimasi un po’ male, ma non mi spiegò dove avevo sbagliato.
Comunque, non lo buttò via. Capii che in fondo non gli era dispiaciuto così tanto e quindi ripetei l’operazione altre volte.
A distanza di anni, ho capito quanto male si può fare nel cercare di fare del bene a tutti i costi. Questo rimorso non mi abbandonerà mai.
Spesso
penso alla sofferenza di mio padre negli ultimi giorni della sua vita e a quanto
ho contribuito anch’io alla sua fine.
Le rare volte che mi appare in sogno ha sempre una mano protesa verso di me.
Non
capisco se mi vuole con lui, oppure se vuole allontanarmi per il male che gli ho
fatto.
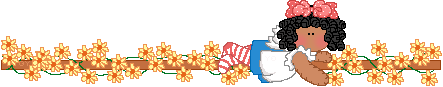
I
testi dei racconti sono di proprietà esclusiva dell'autore (Giana Amantina
e tutelati dagli articoli 2575, 2576 del Codice Civile
( http://www.fiscooggi.it/reader/?MIval=cw_usr_view_articoloN&articolo=23914&giornale=24334 )
Chi ne farà uso, non espressamente autorizzato per iscritto dall'autore, ne risponderà all'autorità giudiziaria in quanto protetti dalla Legge n. 633/1941
sul diritto d'autore.
( http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html )
pubblicato sul sito Il Pozzo Dei Pezzi Pazzi il 28 ottobre 2008 ©
Le immagini di queste pagine sono state reperite nel web e se ne riconosce la proprietà ai rispettivi proprietari
se in qualche modo ho infranto dei copyright, contattatemi e provvederò a rimuoverle o ad inserire l'indirizzo del proprietario.